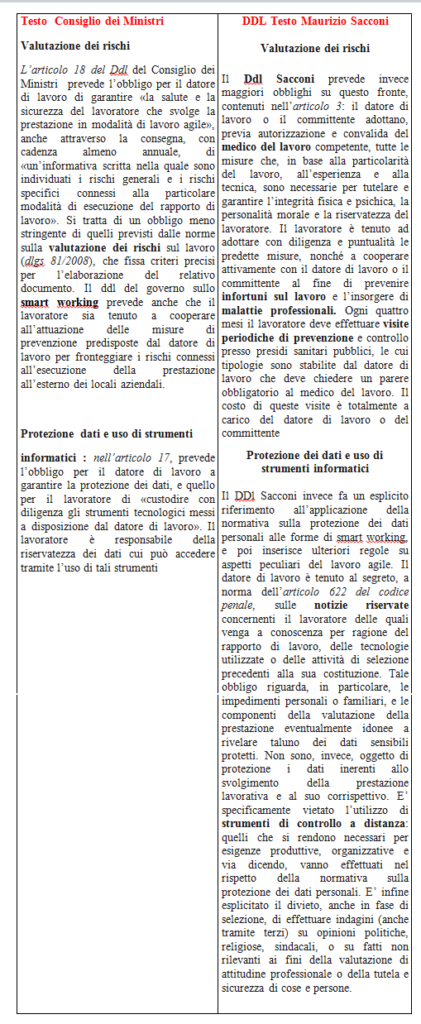Definito come la nuova devianza giovanile, il bullismo è da considerarsi come una forma disfunzionale delle relazioni che s’instaurano tra gruppi di pari, dove i meccanismi sono improntati su ruoli di potere e di controllo. Studi sul fenomeno convengono nell’asserire che, l’essenza del problema risieda nella dilagante necessità di oggi di affermare il proprio potere sull’altro, nell’ambito della propria rete sociale di riferimento (Menesini). E l’altro è percepito solo come strumento per raggiungere un profitto individuale, in quella che ormai è una società che tende a esaltare il sé individuale. Il bullismo non è quindi un fenomene che attiene soltanto la sfera privata (Tourane 2009). E’ anzi un fenomeno sempre più sociale che coinvolge il gruppo dei pari, gli adulti di riferimento e la comunità di appartenenza, mostrando il pieno fallimento dei modelli educativi in corso. Modelli che, come già sosteneva Durkheim, ogni società dovrebbe possedere, per dare a ogni singolo, capacità e mezzi per raggiungere i diversi fini. Ma, a saltare, oggi giorno, sono proprio i cardini di una struttura sociale che non fa che delegare, non trovando più, al proprio interno, validi punti di sostegno. La società postmoderna ha perso i modelli culturali e valoriali di un tempo, e non è stata ancora in grado di costruirne degli altri, tanto da portare i singoli soggetti a confrontarsi con sentimenti d’insoddisfazione, smarrimento e crisi d’identità (Bauman 1999). Il singolo viene quindi a essere l’ingranaggio difettoso di una catena sistemica che non ha saputo far fronte ai cambiamenti, e il bullo è la manifestazione deviata al quale mancano autoconsapevolezza, autocontrollo ed empatia.
Elementi questi, che ci permettono di costruire, nelle diverse fasi della crescita, quella che potremmo chiamare una sana personalità. In ambito psicologico, si sostiene che il soggetto conosca tramite l’apprendimento. Gradualmente prende sempre più coscienza di sé e degli altri attraverso una continua sintesi d’informazioni provenienti dall’esterno, elaborate e restituite sotto forma di linguaggio, comportamenti, azioni. Quando questo processo subisce delle alterazioni, si può incorrere in alcune disfunzionalità. E l’aggressività è da ritenersi una manifestazione di un'identità che, nel corso degli anni, non ha saputo svilupparsi e crearsi correttamente. Anche perché l’aggressività non è l’espressione di elementi innati e dunque immodificabili del singolo. Si acquisisce attraverso l’apprendimento di modelli e norme che ognuno fa propri nel proprio ambiente di vita. (Bandura e Ross). Sull’argomento sono di grande interesse gli studi effettuati dalla psicologa Anna Olivero Ferraris. La dottoressa sostiene che in ognuno di noi è presente un certo quantitativo di aggressività, che non si trasforma necessariamente in violenza se tenuta a freno e incanalata verso obiettivi costruttivi. E questo è il compito che dovrebbe essere svolto dal processo educativo. Un compito che dovrebbe garantire, a ogni individuo, capacità cognitive, sociali ed emozionali tali da permettere d’instaurare corrette relazioni con gli altri e con l’ambiente circostante. Nelle prime fasi della vita, l’apporto familiare è di fondamentale importanza. I bambini tendono a identificarsi con i genitori, i fratelli e le sorelle. Li imitano, e con una serie di azioni e reazioni assimilano le norme e i modelli di comportamento vigenti al loro interno. Attraverso il gioco poi, il bambino socializza ed esterna tutto il suo mondo interiore, confrontandosi con il gruppo dei pari. Gli insegnamenti familiari si applicano, e l’indole si manifesta. In questa fase, dove il sé s’incomincia a interfacciare con il mondo esterno, il bambino prende coscienza dell’esistenza dell’altro, e si attua il processo di differenziazione. E’ facile però, che in questa fase, si presenti una forma molto comune di aggressività, tipica tra i bambini piccoli, che è quella di strappare dalle mani degli altri il gioco. Questa però, non bisogna confondersi, è un’aggressività di tipo fisiologico, non intenzionale, dovuta alla mancanza di proprietà di linguaggio e all’incapacità di attendere il proprio turno. Con l’età, e quindi con lo sviluppo di nuove capacità relazionali, questo tipo di aggressività dovrebbe attenuarsi e sparire del tutto. Quando però, ci si trova davanti a bambini con dei deficit a carico delle abilità sociali, definiti da Dodge Social Skill Deficit Model, la situazione potrebbe essere di tutt’altro tipo. I bambini nei quali si riscontrano queste difficoltà tendono a non elaborare correttamente le informazioni sociali, avendo a loro disposizione, un numero di risposte agli imput esterni più limitato rispetto agli altri, e quasi esclusivamente di tipo aggressivo. E questo è dovuto alla loro incapacità di mettere in atto comportamenti adeguati alle diverse situazioni sociali a causa proprio della qualità della codifica, deficitaria in alcuni punti del processo relazionale. In soggetti di questo tipo, il processo educativo ha portato in molti casi a sovrastimare gli atteggiamenti degli altri e dell’ambiente circostante, sottostimando i propri. La reazione, è vista come un modo per farsi rispettare, avere tutto e subito, è l’espressione della propria personalità, e primeggiare sugli altri, significa essere dei vincenti. Per questi bambini, l’aggressività non è più quella fisiologica ma si è ormai trasformata in aggressività intenzionale finalizzata a far del male per ottenere quel che si vuole.
Se ovviamente questi atteggiamenti non trovano negli anni dei validi supporti educativi che li correggano, l’aggressività può sfociare in vero e proprio malessere, facile da riscontrarsi nell’età preadolescenziale. In questa fase, nodo cruciale della crescita dell’individuo, il soggetto impara ad affermarsi cercando il pieno distacco dalla famiglia d’origine, per identificarsi maggiormente nel gruppo dei pari. Un gruppo nel quale è molto facile perdere la propria identità, per far spazio all’identificazione (Anna Olivero Ferraris). Ci s’identifica per appartenere, per essere accettati e molto spesso per non essere presi di mira. Nel gruppo si passano svariate ore della giornata, per sopperire alle mancanze di una famiglia assente. Una famiglia, che sin dai primi mesi di vita, ha necessità, per motivi lavorativi, di lasciare i propri figli al nido. Figli che già da così piccoli cominciano a percepire maestre e compagni come i loro veri punti di riferimento. E tutto questo non si può non tenerlo nel dovuto conto, soprattutto per l’impatto che ha avuto nella crescita evolutiva, portando tanti bambini, ragazzi e poi adulti, a vivere quella che Beck ha definito come la nuova vita sperimentale. Una vita nella quale i vecchi canali educativi non esistono più, e i nuovi hanno fallito crescendo generazioni insoddisfatte capaci solo di riversare sugli altri la loro impotenza sotto forma di un’aggressività che attacca per far in modo di non essere attaccati mostrando così a tutti le proprie debolezze.
Dott.ssa Tania Nardi